“Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda. Noi ci dobbiamo ribellare. Prima che sia troppo tardi, prima di abituarci alle loro facce, prima di non accorgerci più di niente.”
-Giuseppe Impastato
Con queste parole Giuseppe Impastato, cresciuto in una famiglia mafiosa di Cinisi, invitava a ribellarsi contro il non vedo, non sento, non parlo su cui la criminalità organizzata fonda la sua forza.
Peppino lottava contro la mafia perché proprio la mafia, fondata su corruzione, gerarchia, machismo e violenza, è la massima resistenza possibile al riscatto sociale dellɜ lavoratorɜ, delle donne, dellɜ ultimɜ, dellɜ marginalizzatɜ.
Peppino era un militante comunista, parte della lunga storia di lotta del movimento dellɜ lavoratorɜ per il riscatto della propria terra dalla violenza del Capitale che assumeva quasi interscambiabilmente il volto del latifondista, dell’imprenditore senza scrupoli, del capo mafia.
È la storia di un’antimafia sociale fatta di organizzazione, cultura, solidarietà, senso civico, democrazia, lotta: in altre parole è una storia di giustizia sociale.
In un tempo in cui la criminalità organizzata si fa multinazionale, diviene massimamente pervasiva di ogni aspetto dell’economia illegale e legale e per fare ciò si avvale di professionalità di altissimo livello prestate al crimine, abbiamo l’esigenza di continuare lungo questa strada e di trovare nuovi modi e nuove strade per aggiornare la lotta alle mafie.
Come studentɜ e giovani sappiamo benissimo quanto fondamentale sia il ruolo di scuole ed università nella costruzione di una mentalità civica e democratica ma viviamo anche sulla nostra pelle le manchevolezze strutturali di questo paese che negli anni hanno spinto milioni di noi a lasciare l’Italia (solo in Sicilia sono 50.000 ogni anno lɜ giovani che lasciano la propria terra) e coloro che sono ancor meno fortunatɜ ed impossibilitatɜ ad andare via a cadere nel circuito della criminalità organizzata.
In un paese che non garantisce realmente il diritto al futuro delle giovani generazioni, in cui la precarizzazione del mondo del lavoro ha raggiunto picchi gravissimi e in cui il definanziamento dei servizi pubblici non fa che aggravare la peggiore crisi povertà della storia della Repubblica e il tasso di astensionismo alle ultime tornate elettorali ci parla di un paese lontano dalla politica, si allarga a dismisura quella zona di marginalità e fragilità sociale nella quale le mafie trovano lo spazio per porsi come “stato contro lo stato” capace di offrire alternative al vuote colpevole che delle istituzioni viste come sempre più lontane creano ogni giorno.
Ripartire da scuole ed università così come dall’antimafia sociale non può che voler dire oggi quindi tornare a parlare e praticare giustizia sociale e democrazia: si tratta oggi di tornare parlare della dignità della persona, dei suoi diritti e delle sue condizioni materiali, tornare a costruire un’etica civica e uno spirito comunitario, tornare ad avere diritto a restare e costruire un futuro migliore.
Dobbiamo avere il coraggio di continuare lungo la strada tracciata dal movimento dei fasci siciliani, da Placido Rizzotto, Giuditta Levato e da tuttɜ lɜ altrɜ sindacalistɜ morte nella lotta per la dignità di chi non ha nulla, da Danilo Dolci e dai suoi insegnamenti sulla nonviolenza e sulla pedagogia, dal sacrificio di politichɜ, attivistɜ e giornalistɜ come Bernardino Verro, Giuseppe Impastato, Pio La Torre e Giuseppe Fava.
Non è una strada semplice ed è in netto contrasto con la visione securitaria della lotta alle mafie e al degrado che questo governo sta portando avanti con il DDL “Sicurezza” e rifiutando di pensare percorsi di reinserimento sociale all’interno di quartieri e città di chi è stato intercettato dall’ambiente criminale.
La risposta migliore, alla criminalità organizzata così come alle risposte di facciata di certa politica è la lotta e l’organizzazione. Noi ci dobbiamo ribellare!
MARGINALIZZAZIONE E INVISIBILIZZAZIONE
La lotta dell’antimafia sociale è strettamente legata alla tematica dell’invisibilizzazione: le soggettività marginalizzate e abbandonate a sé stesse sono da sempre terreno fertile per le mafie, venendo sfruttate come manodopera o stritolate dalla violenza sistemica. Questa connessione risulta evidente nel fenomeno di matrice mafiosa del caporalato attraverso il quale lɜ lavoratorɜ agricolɜ, spesso soggettività migranti sotto minaccia, vengono sfruttatɜ dalle aziende del settore primario. In questa cornice si inserisce l’intersezione tra antimafia sociale e lotta per la cittadinanza: dal momento che le mafie tendono a sfruttare le soggettività appartenenti alle categorie marginalizzate, come l3 migranti, intervenire per garantire a queste soggettività diritti e possibilità dignitose significa combattere l’egemonia che il sistema mafioso riveste nelle vite di quest’ultime.
La crescita del fenomeno del caporalato negli ultimi anni, principalmente al Sud, è indicativa della tendenza delle mafie ad agire sulle periferie del sistema istituzionale, in un contesto dove politiche securitarie e repressive vengono vendute come unica soluzione alla questione mafiosa, mentre le politiche sociali sono continuamente messe in secondo piano.
Proprio sulle tematiche della dispersione scolastica, delle disuguaglianze e del securitarismo deve svilupparsi la nostra analisi delle politiche dell’attuale governo, in quanto, come dicevamo prima, il fenomeno mafioso trova spazio per espandersi soprattutto nelle zone di marginalità dove lo Stato volta le spalle e abbandona le soggettività, mancando di politiche di prevenzione che possano contrastare l’insorgere di questi fenomeni in maniera radicale, ovvero partendo dalle radici dei problemi. L’ultimo rapporto Oxfam dice molto sullo stato delle disuguaglianze nel nostro paese: nel 2022, circa 5,6 milioni di individui versavano in condizioni di povertà assoluta, condizione che negli anni successivi è andata unicamente peggiorando e che continuerà in questa direzione nei prossimi anni, in quanto misure come l’Autonomia Differenziata faranno altro che acuire il divario tra Nord e Sud. È evidente come in un contesto di forte disuguaglianza sociale ed in mancanza di politiche di redistribuzione della ricchezza volte a risolvere tali disuguaglianze, le organizzazioni mafiose si presentino alle soggettività marginalizzate come alternativa quasi salvifica, per poi stritolarle nella loro morsa senza permettergli di uscirne.
Nel costruire il nostro modello di antimafia, dobbiamo tener conto anche di fattori quali la dispersione scolastica e i servizi territoriali: in un contesto nazionale ormai dominato dalla gentrificazione e dalla turistificazione selvaggia, che spinge sempre di più le città a diventare vetrine a uso e consumo dei turisti, escludendo e ghettizzando lɜ marginalizzatɜ, spesso strettɜ tra la violenza del sistema mafioso ed il cannibalismo del sistema capitalista, emarginate nelle loro stesse città dallo Stato con misure repressive come il “Decreto Zone Rosse”, lo stesso Stato che mette l’istruzione e la sanità all’ultimo posto, aumentando i fondi alle scuole paritetiche, il nostro compito fondamentale è costruire l’alternativa sui territori.
Per costruire un’alternativa tangibile a partire dalla nostra analisi politica, come Rete della Conoscenza ci dotiamo di diversi strumenti, che vanno dalle campagne che costruiamo da giovani per lɜ giovani alla costruzione di reti sociali, di cui tratteremo meglio più avanti. Rispetto alle campagne che stiamo costruendo e che si inseriscono bene nella cornice della lotta alla marginalizzazione, rivestono grande importanza come “Non è un paese per giovani” e “WorkerZ”, che hanno come target primario l3 giovani, in particolare precariɜ e soggetti in formazione; campagne che hanno come temi rispettivamente la garanzia dei servizi territoriali e il contrasto alla precarietà giovanile. Inoltre, come RdC abbiamo aderito e contribuiamo a diffondere i 5 quesiti referendari per quanto riguarda la cittadinanza e il lavoro dignitoso, oltre che alle due Reti – Rete a Pieno Regime e Rete Liberi/e di Lottare – di contrasto al securitarismo del DDL Sicurezza. Riteniamo questi processi, in cui entriamo con una postura di sintesi e costruzione, estremamente importanti al fine di costruire attraverso il movimento una forza unitaria nella lotta alle disuguaglianze, alla marginalizzazione e all’invisibilizzazione e contribuire così al anche al contrasto alla criminalità organizzata .
FARE RETE PER UN’ANTIMAFIA SOCIALE E POPOLARE
Fare antimafia sociale significa costruire un’alternativa concreta di sviluppo per le nostre comunità, un’alternativa al ricatto mafioso, alla povertà che alimenta tale ricatto e che rende la criminalità un’opzione allettante. Significa affrontare la miseria che questo sistema genera, l’assenza di prospettive dignitose, le difficoltà a condurre una vita rispettosa della propria dignità, a istruirsi, a lavorare in maniera onesta, a costruire relazioni libere e ad avere speranza nel futuro.
Per realizzare questa alternativa, è necessario unire tutte le forze a disposizione: istituzioni, sindacati, associazioni, cooperative e il tessuto economico locale devono interagire e lavorare insieme.
L’esperienza ci ha dimostrato che l’incubatore naturale per queste alleanze è stata spesso la necessità di collaborare per partecipare ai bandi destinati al riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia.
Secondo il report “Raccontiamo il bene” di Libera contro le mafie, basato sui dati dell’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, a febbraio 2024 i beni immobili destinati risultano essere 22.548, mentre quelli effettivamente in gestione sono circa 19.871, segnando un calo rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda le aziende, quelle destinate ammontano a circa 3.126, con un aumento del 77% rispetto al 2023. I “beni destinati” sono quelli che hanno completato l’iter legislativo e sono stati trasferiti ad altre amministrazioni per scopi sociali. Tuttavia, il fatto che un bene venga destinato non implica automaticamente che venga riutilizzato in modo sociale. Attualmente, sono 1.065 i soggetti coinvolti nella gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, concessi in uso agli enti locali in 18 regioni italiane. Tra questi ci sono 563 associazioni, 232 cooperative sociali, 39 associazioni del terzo settore, 6 comunità e 31 enti pubblici. La Sicilia è la regione con il maggior numero di realtà sociali che gestiscono beni confiscati, con 285, seguita dalla Campania (170), dalla Lombardia (151), dalla Calabria (149), dalla Puglia (123), dal Lazio (54) e dal Piemonte (41), confermando la presenza mafiosa su tutto il territorio nazionale. Le attività svolte sui beni confiscati riguardano per il 56,8% welfare e politiche sociali, per il 25,6% la promozione culturale e il turismo sostenibile, per il 10% l’agricoltura e l’ambiente, e per il 4,7% la produzione e il lavoro.
Questi dati evidenziano l’enorme investimento mafioso nel territorio e l’importanza di seguire ancora oggi l’insegnamento di Giovanni Falcone: “segui il denaro e troverai la mafia”. Eppure, sempre più spesso, seguendo questi flussi finanziari si scoprono storie di un’antimafia concreta ed efficace, che offre una risposta sociale positiva e tangibile.In questo processo, i giovani svolgono un ruolo fondamentale. Cresciuti in un contesto segnato da crisi economiche, con la pandemia che ha acuito le difficoltà socioeconomiche, abituati a una precarietà che inizia dai banchi di scuola, i giovani sono oggi una delle categorie più vulnerabili al fascino del crimine organizzato e dei suoi benefici assistenzialistici. Allo stesso tempo, sono anche il motore possibile del riscatto sociale. Sono infatti molti lɜ giovani che, nonostante le difficoltà, scelgono di impegnarsi nel sociale, promuovendo cambiamenti positivi nella comunità.
Laddove la rassegnazione per le proprie condizioni economiche e sociali si fa imperante la speranza per una vita migliore tende a spegnersi, lì c’è bisogno di iniziare ad organizzare la lotta dellɜ subalternɜ e dellɜ marginali. È un insegnamento che viene da lontano, dalla storia del movimento dellɜ lavoratorɜ per il riscatto della propria condizione e per la libertà e la giustizia delle e nelle proprie terre. È la storia in Sicilia dei fasci siciliani e della lotta delle leghe dei braccianti e del sindacato contro il latifondo e il dominio mafioso: è persone che hanno lottato e sono cadute per guadagnare ad ognuno una vita dignitosa e libera, una storia di unione e solidarietà di cui dobbiamo riannodare i fili.
Per questo motivo, è necessario partire dall’incontro tra esperienze locali di resistenza e solidarietà: di questo sforzo Iɜ giovani, spesso al centro delle realtà che combattono contro le ingiustizie sociali, sono un elemento fondamentale.
Come Rete della Conoscenza, la rete delle organizzazioni giovanili più grande del paese, lavoriamo ogni giorno per creare spazi di partecipazione e decisionalità, affinché le nuove generazioni possano essere protagoniste del loro futuro, costruendo un’alternativa solida e sana alla criminalità e alle sue logiche. Riannodiamo i fili insieme e ribelliamoci allo status quo insieme, conquistiamo il futuro.
ISTRUZIONE: PRIMA ARMA NELLA LOTTA CONTRO LE MAFIE
Nel nostro Paese, da anni, assistiamo a una situazione disastrosa riguardante l’edilizia pubblica in merito a scuole ed università. Questa situazione, sia in termini di sicurezza delle strutture sia per quanto riguarda il sovraffollamento delle aule, ha dato vita al fenomeno delle cosiddette “classi pollaio”: la situazione è emersa in modo evidentissimo durante la fase pandemica, ma esistevano da molto prima.
Parlare di edilizia scolastica è fondamentale non solo perché le mancanze vanno a limitare e mette a rischio lɜ studentɜ, ma anche perché blocca la didattica rendendola sempre più sterile e frontale.
Sul territorio nazionale esistono numerosi beni confiscati alle mafie che, con un adeguato investimento, potrebbero essere trasformati in spazi scolastici o aggregativi per studenti come già avvenuto in oltre 30 casi andando a costituire una parziale risposta al problema.
Convertire questi luoghi da simboli della mafia e dello sfruttamento mafioso in spazi di formazione e conoscenza non significa soltanto ampliare le infrastrutture educative, ma anche promuovere una cultura di lotta e resistenza alerentiva.
Ci sono vari spazi nati dalla collaborazione tra associazioni universitarie\giovanili e realtà territoriali, che offrono non solo un luogo sicuro per studiare, ma anche un punto di riferimento per la città tutta. Sono esempi di “edilizia educante”: spazi fisici che non si limitano a ospitare attività didattiche, ma che incarnano un modello di società diverso, basato sulla condivisione della conoscenza e sulla lotta.
Per spezzare definitivamente il dominio mafioso, la formazione non può limitarsi ai soli luoghi tradizionali dell’istruzione. Serve un’educazione permanente, capace di sviluppare un pensiero critico che accompagni le persone lungo tutto il corso della loro vita. In questo senso, anche l’informazione gioca un ruolo cruciale eppure i media, compreso il servizio pubblico, trattano sempre meno il tema delle mafie, relegandolo a episodi spettacolarizzati, che alimentano l’immaginario stereotipo del mafioso come figura brutale, ignorante e fuori dal tempo. Questo tipo di narrazione oscura e minimizza la realtà di un sistema mafioso che, oggi più che mai, si intreccia con l’apparato statale e sfrutta in maniera sofisticata le opportunità offerte dal contesto socio-economico e politico.
Viviamo in un mondo in cui gli strumenti che dovrebbero essere promotori di cultura e consapevolezza si piegano alla logica dell’audience, riducendo l’informazione a titoli sensazionalistici e notizie lampo.
Come giovani del paese, rivendichiamo un’educazione continua e diffusa che non lasci spazio ad organizzazioni mafiose, che vada oltre scuole e università e formi cittadine e cittadini consapevoli, capaci di interpretare criticamente il mondo e di poterlo cambiare in meglio.
Vorremmo che la lotta alla mafia non sia fatta solo da parole, ma che si basi anche su fatti e esperienze virtuose, che siano la base per ridare significato a tutti quei territori inquinati e deturpati dalle mafie.
Un altro grande problema del nostro paese che lega istruzione e criminalità organizzata è il tema della dispersione scolastica che in italia vede uno dei tassi più alti in Europa. In contesti dove la mafia è forte, questo fenomeno può aumentare per vari motivi: le famiglie che vivono in contesti di povertà, spesso legati a zone in cui la mafia è presente, potrebbero non essere in grado di sostenere i costi dell’istruzione o potrebbero avere minori opportunità educative. In alcune zone la mafia può avere una presa così forte da spingere lɜ giovani a credere che la vita criminale sia una possibilità di realizzazione migliore di quelle offerte dall’istruzione e da una vita onesta..
È per questo motivo che la Mafia e il lavoro nero trovano terreno fertile nel reclutare minori, dove la dispersione tocca livelli da primato europeo e dove assistenti sociali e centri aggregativi sono assenti o assolutamente non all’altezza: basti pensare che le percentuali di abbandono scolastico tocca rispettivamente il 17,1% in Sicilia, il 16,8% in Campania e l’11,8% in Calabria.
La criminalità organizzata recluta soprattutto lɜ più giovani come bassa manovalanza per la gestione di attività illegali, in primis lo spaccio di sostanze stupefacenti, facendo leva sulla fragilità, se non quando l’assenza della comunità educante.
Anche in questo caso sono i numeri a parlare: nel 2019 le quote di denunce per associazione a delinquere (anche di tipo mafioso) a carico di minorenni in Campania, Sicilia e Calabria erano più elevate del paese (0.85% in Calabria,0,96% in Sicilia e 1,04% in Campania).
E’ evidente quindi come il tema della dispersione scolastica sia centrale: coloro che sfuggono all’istruzione pubblica cadono con estrema facilità nella rete della criminalità organizzata andandone ad ingrossare le fila.
Come giovani e studenti di questo paese crediamo ci sia la necessità di avere una risposta da parte delle istituzioni nello spezzare questa catena che trova origine dall’istruzione escludente e che vede tantissimi decidere di abbandonare il percorso formativo trovando risposta in percorsi mafiosi.
Vogliamo costruire un modello di formazione che sia davvero partecipativo, in cui la conoscenza non sia qualcosa da ricevere passivamente, ma da creare e condividere insieme, in quanto crediamo che solo attraverso la partecipazione attiva, il dibattito, la liberazione e la condivisione dei saperi si possa sviluppare in sapere realmente condiviso, che sia in grado di decifrare le contraddizioni del presente e immaginare un futuro diverso. Per fare ciò ci dotiamo di strumenti che favoriscono il confronto, l’apprendimento attivo e la crescita collettiva, strumenti come assemblee pubbliche, workshop, autoformazione, strumenti che ci permettono di indagare i vari bisogni della comunità studentesca e di costruire una realtà migliore partendo da ciò.
Lo facciamo anche attraverso l’approvazione di codici etici, attraverso la presa in carico di beni confiscati, attraverso la cooperazione con realtà territoriali per tutelare l’ambiente e attraverso la costruzione di reti sociali.
L’educazione è uno strumento di liberazione, e affinché lo sia realmente deve essere accessibile, permanente e radicalmente democratica. Questo significa investire in spazi adeguati e gratuiti, garantire risorse tramite la formazione continua e diffusa, promuovendo un sapere partecipativo ed orizzontale.
Scuola e cultura sono le prime armi per vincere la battaglia contro la criminalità organizzata.
REPRESSIONE E MAFIA
A livello mediatico e nella discussione pubblica più in generale, la lotta alle mafie viene sempre collegata all’utilizzo di strumenti repressivi e al rafforzamento delle forze dell’ordine.
Negli anni passato, al centro del dibattito sul contrasto alle mafie c’è stata, per assurdo, la vicenda di Alfredo Cospito e la conseguente discussione sul 41Bis. Chiunque provasse a portare una critica a un modello di detenzione che disumanizza e non rieduca le persone soggette a questo regime carcerario, veniva additato come filomafioso e complice con persino pareri giurisprudenziali utilizzati per derubricare chi si opponeva alla misura ad un collaborazionista della criminalità organizzata.
Aseguito della vicenda di violenza sessuale di Caivano e il conseguente decreto legge, si è poi scelto ancora una volta lo strumento della repressione come modalità principale per combattere la criminalità organizzata. Il decreto, nei fatti, come riportato anche da una recente inchiesta dell’associazione Antigone, non ha fatto che rafforzare la dispersione scolastica, il sovraffolamento carcerario minorile e l’indebolimento dei processi di reinserimento nella società dei minori e dell3 giovani che hanno commesso reati puniti con la carcerazione e non. Come se non bastasse, il governo sta ora cercando di applicare il cosiddetto modello Caivano anche ad altre zone del paese tra cui spicca il quartiere romano del Quarticciolo, quartiere difficile e marginalizzato ma animato da una comunità orgogliosa e battagliera i cui spazi di mutualismo e solidarietà sono ora minacciati.
Nel Ventesimo rapporto sulle condizioni di detenzione si evidenzia che solo nell’ultimo anno la crescita delle presenze nelle carceri di tutta Italia è stata in media di 331 unità al mese. Crescono dunque le presenze e quindi cresce anche il tasso di affollamento ufficiale, che raggiunge a livello nazionale il 119,3%. Inoltre, nonostante la crescita degli ingressi di fatto le persone in carcere con un lungo residuo di pena da scontare stanno aumentando, tanto nei numeri assoluti quanto in percentuale sul totale. La causa di tutto questo non è certo un aumento della criminalità per i fatti più gravi, che è in calo. Il fenomeno dipende invece dall’innalzamento delle pene, una tendenza che si registra da anni, e che comporta, oltre all’invecchiamento della popolazione detenuta, anche una crescita delle presenze in carcere che prescinde dall’aumento degli ingressi. Inoltre, lo stesso CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) rivela il significativo abisso che separa il (terribile) tasso di recidiva del 70%, stimato sull’attuale popolazione carceraria, con quello di solo il 2% che si ottiene se si limita l’osservazione ai circa 20mila detenuti che hanno un contratto di lavoro.
Risulta evidente come il sistema carcerario, più che efficiente contromisura ai fenomeni criminosi e mafiosi, sia in primis strumento di repressione e di criminalizzazione della povertà e non una reale soluzione. Non ci si pone l’obiettivo di superare le condizioni sociali e materiali che creano l’humus fertile in cui nascono e prosperano le organizzazioni criminali ma si invisibilizzano e colpevolizzano tutt3 coloro che vivono situazioni di disagio sociale ed economico.
Inoltre risulta incomprensibile come ci si concentri sugli aspetti di microcriminalità della questione e si faccia finta di non vedere il gigantesco fenomeno della corruzione e della commistione tra potere politico e mafie. L’italia è al 42° posto mondiale per assenza di corruzione con un punteggio di dieci punti inferiore alla media europea ed è il paese dell’Europa occidentale nella posizione più bassa. Ogni mese nel nostro paese viene commissariato un ente locale per mafia, senza considerare tutte le dimissioni in blocco di comuni per indagini che non rientrano nel conteggio dei comuni sciolti. Nel solo 2023 ci sono stati 18 provvedimenti tra Campania, Calabria, Sicilia e Lazio.
La nostra antimafia non può che ribaltare questo paradigma e rifuggire da qualsiasi forma repressiva di gestione dei fenomeni mafiosi. Quelli che bisogna aggredire non sono i singoli individui portatori delle contraddizioni del loro contesto sociale, ma il contesto sociale stesso fatto di povertà materiale e incultura, un contesto sociale fatto di assenze di prospettive di riscatto che non siano legate alle organizzazioni criminali. Bisogna aggredire i patrimoni della criminalità organizzata che sono sottratti illegittimamente alla collettività. Bisogna aggredire quella cultura che non permette di immaginare prospettive di riscatto individuale e collettivo.
Per questo chiediamo un nuovo paradigma di società che metta al centro la risoluzione dei bisogni materiali, che permetta lo strumento dei saperi liberi come emancipazione, che crei un modello rieducativo nel caso si sbagli e non una punizione senza redenzione, una società in cui la presenza delle istituzioni sia per il supporto attivo e non per la criminalizzazione della povertà.
Per questo diciamo no alla repressione, sì alla società della cura, per un’antimafia sociale e popolare.
COME GIOVANI SENZA SPERANZA DI UN FUTURO MIGLIORE, CONTRO LE MAFIE E QUESTO SISTEMA ECONOMICO-POLITICO CHE, QUANDO NON COLLABORA ATTIVAMENTE CON ESSE, COLPEVOLMENTE CREA DESERTI DOVE QUESTE POSSONO CRESCERE, COSTRUENDO L’ALTERNATIVA DEMOCRATICA E SOCIALE CHE MANCA SUI NOSTRI TERRITORI,
CI DOBBIAMO RIBELLARE
Cos’è la Rete della Conoscenza? La Rete della Conoscenza (RdC) è la rete delle associazioni giovanili e studentesche che lottano per il diritto ad un futuro libero e giusto per le giovani generazioni. Sono soci della RdC l’Unione degli Studenti, LINK-Coordinamento Universitario e le realtà giovanili territoriali confederate.
L’Unione degli Studenti (UdS) è il più grande sindacato studentesco del paese nato nel 1994. Lotta nella scuola e fuori per i diritti dellɜ studenti e per il protagonismo studentesco nella società.
LINK-Coordinamento Universitario (LINK) è il coordinamento dellɜ studenti indipendenti che lottano nell’università e fuori di essa contro baronati, lobby e meritocrazia tossica per un’altra università, gratuita e per tuttɜ non per pochɜ.
Se vuoi lottare per avere un futuro migliore unisciti a noi, entra in Rete!
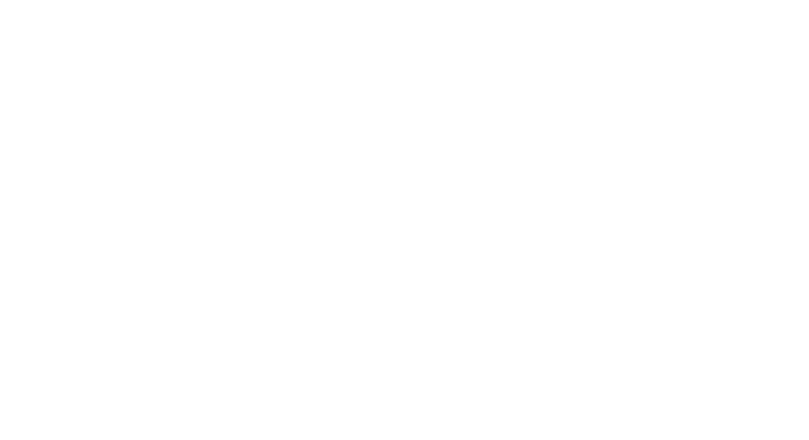

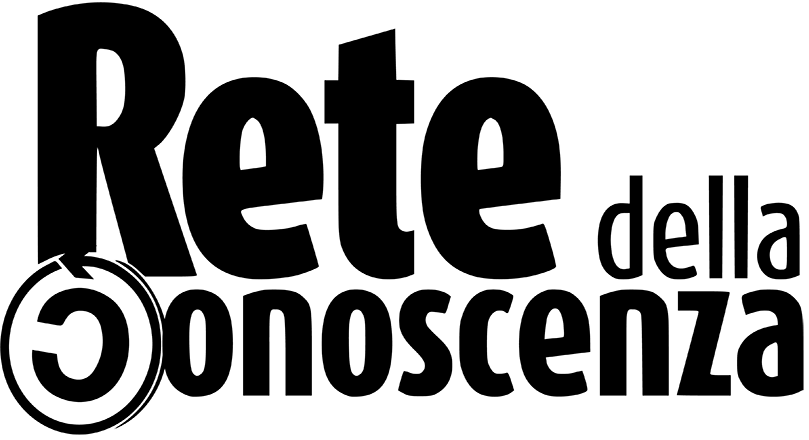
Lascia un commento